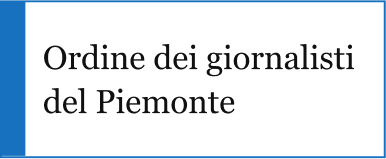La giusta distanza per raccontare i drammi del mondo
Le riflessioni su giornalismo e migrazioni in un incontro con gli universitari di Gorizia
Sono stato invitato dagli studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia a ragionare sul ruolo dell’informazione nel racconto della vita di uomini e donne all’interno dei campi profughi, un tema che sempre più ricorrentemente si affaccia nelle cronache anche se talvolta trattato senza le dovute accortezze. Un incontro che si è svolto nell’ambito di “è Storia”, un festival che mette a confronto ogni anno esperti di tutto il mondo sulle complesse dinamiche del nostro tempo.
Nel mio percorso professionale ho avuto l’occasione di conoscere e raccontare diversi tipi di campi profughi in situazioni che in qualche modo descrivono anche l’evoluzione di queste strutture che nascono spesso come ricoveri provvisori e che poi, con il passare del tempo, tendono a trasformarsi in vere e proprie città. È questo, ad esempio, il caso di “Aida”, quello che è oggi il primo quartiere di Betlemme a ridosso del muro di separazione e che visitai nel 2013 facendo parte di una missione umanitaria. A ricordare che nel 1948 quello era un accampamento che ospitava i rifugiati della prima guerra mediorientale è rimasta una porta di ingresso sovrastata dalla chiave simbolo dell’esodo palestinese. Per il resto, quello spazio fatto di vie anguste è oggi a tutti gli effetti un pezzo di città nel quale le costruzioni in muratura, seppur povere e in parte cadenti,
hanno preso del tutto il posto delle prime tende. Un processo simile a quello che ho osservato nel 2015 nel campo di Domiz nel Kurdistan iracheno (foto qui a fianco) durante le riprese del documentario “Dust”, un luogo nel quale vivevano e vivono oltre centomila mila persone.

Lì il processo di trasformazione del campo era appena iniziato, ma in questi anni è proseguito inesorabilmente e la ragione molto semplice: ad abitare queste strutture sono spesso persone per le quali non esiste la possibilità del rientro a casa perché le loro abitazioni sono state distrutte o perché le condizioni di sicurezza non forniscono alcuna garanzia. Una condizione del tutto simile a quella dei migranti in transito sulla rotta balcanica nei quali mi sono imbattuto più recentemente nella zona di Bihac dove ho raccontato il prezioso lavoro di soccorso svolto dalle organizzazioni umanitarie italiane (nella foto sotto Vucjak). Temi complessi che non hanno lasciato indifferente la mia coscienza e tuttavia è stato ancor più difficile rispondere alla studentessa che mi ha domandato come sia possibile mantenere distacco nel descrivere queste situazioni e come sia poi possibile tornare alla comoda vita di tutti i giorni dopo essere entrati a contatto con tanto dolore. È la stessa domanda che si potrebbe porre alle decine di colleghe e colleghi che, anche in queste settimane, stanno raccontando i conflitti in corso. Non esiste, credo, una risposta giusta o una risposta che valga per tutti, ognuno fa i conti da solo con la propria coscienza.

Per quanto mi riguarda credo però che lo sguardo del giornalista, anche in questi contesti, non debba perdere la sua terzietà. Ne va dell’oggettività del suo racconto e quindi anche della credibilità delle testimonianze alle quali decide di dare voce.
La giusta distanza non è facile da raggiungere ma è la prospettiva corretta anche per sventolare la sola bandiera che siamo autorizzati a imbracciare, quella della difesa dei diritti umani. Una questione mai scontata, come le cronache di queste settimane ci stanno ricordando.
Stefano Tallia, Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte